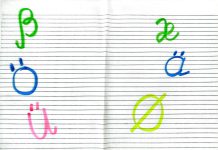Se tradurre, oltre che viaggiare e conoscere, significa unirsi a un grido di libertà, a un inno di pace e tolleranza
Quando molti anni orsono, giovane matricola della SSLMIT dell’Università degli Studi di Trieste, scelsi di studiare il nederlandese(1) mai avrei immaginato che grazie a questa lingua avrei viaggiato, se non proprio «nella valle tra il Tigri e l’Eufrate» come sognavo da bambina, nel paese non meno segreto e seducente a ridosso della «culla della civiltà», l’Iran. Un paese la cui cultura e le cui vicende storiche si sono potentemente intrecciate con quelle dell’Occidente e che ancora oggi resta più che mai al centro degli equilibri mondiali.
Ancora più remota era allora l’idea che nella mia professione di traduttrice editoriale avrei incontrato un aspirante scrittore iraniano destinato a realizzare il suo sogno nei Paesi Bassi, scegliendo la lingua olandese come nuova patria.
Kader Abdolah, nom de plume di Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, arriva in Olanda nel 1988 in fuga dalla Persia (come ama chiamare la sua madrepatria), dov’era membro di un movimento clandestino d’ispirazione marxista che mirava a rovesciare il potere costituito. Con il ritorno dall’esilio dell’Ayathollah Komehini, che nel 1979 porta alla nascita della Repubblica islamica dell’Iran, il nemico da abbattere diventa il regime clericale sciita. Ma quando la SAWAK, la famigerata polizia segreta, è ormai sulle sue tracce, Hossein è costretto a lasciare la sua terra e approda come rifugiato politico nei Paesi Bassi. Qui impara l’olandese da autodidatta, leggendo i celebri libri per bambini di Annie M.G. Schmidt (da qualche anno tradotti anche in italiano(2)). Il linguaggio dei piccoli protagonisti delle storie illustrate di Schmidt è semplice, chiaro, fatto di frasi brevi, e avrà un’influenza decisiva sullo stile di Abdolah, introducendolo a quella limpida concretezza che contraddistingue non solo la lingua ma anche la cultura e la letteratura dei Paesi Bassi.
Come autore in erba che ha eletto il nederlandese a suo nuovo idioma («Gli ayatollah avevano sequestrato la mia lingua, non potevo più esprimermi liberamente in farsi», ripeterà in molte interviste negli anni a venire), Hossein decide di assumere un nuovo nome, unendo quelli di due compagni di lotta, Kader e Abdolah, messi a morte dal regime teocratico. Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di «dare voce a chi non può più parlare», di «continuare a lottare con la penna». Anche il titolo di una delle due raccolte di racconti con cui esordisce alla scrittura per i tipi di De Geus – la prima casa editrice olandese a intercettare, sul finire degli anni Ottanta del Novecento, il nascente filone della «letteratura meticcia o migrante» – indica la missione che Abdolah si è dato- De meisjes en de partizanen (Le ragazze e i partigiani, 1993) racchiude infatti pagine dolenti, in cui il tema della lotta di resistenza si intreccia con la nostalgia della terra natale, delle sue montagne scoscese, dei suoi fiumi impetuosi, così diversi da quelli placidi che attraversano il paese piatto e piovoso che lo ha accolto.
Se la fase aurorale della letteratura di migrazione ha ovunque una matrice biografica, in Kader Abdolah la dimensione personale non è mai disgiunta da quella politica. La traiettoria della sua vita ha intersecato quella della storia e lui traduce questo evento in un’esperienza letteraria, in un racconto che ripercorrendo gli accadimenti storici si fa memoria e ammonimento, senza rinunciare alla dimensione inventiva e poetica. I despoti passano – è il concetto di fondo – la letteratura resta e continua a nutrire e a interrogare chi legge.
D’altronde sarebbe sbagliato ridurre la narrativa di Abdolah a mera scrittura autobiografica o militante. Se il dovere della testimonianza rappresenta la pietra angolare del suo scrivere, Abdolah si dimostra fin da subito anche capace di trascendere la propria vicenda individuale e di farsi interprete di temi universali. Già nel Viaggio delle bottiglie vuote(3) la nostalgia dell’esule assurge a ode degli affetti familiari e nella solitudine del protagonista, l’immigrato Bolfazl, risuona l’emarginazione di ogni reietto, diverso o escluso, come René, il suo vicino di casa omosessuale.
Analogamente in Scrittura cuneiforme Abdolah sa trasfigurare la dannazione di chi è costretto all’esilio, così come il suo senso di colpa per i legami familiari recisi e la patria abbandonata, in un racconto epico in cui il giovane Ismail, riparato in Olanda, prende atto della cesura avvenuta nella sua vita e della necessità di affacciarsi a un nuovo presente. Scrittura cuneiforme(4) è quindi un sofferto romanzo dell’addio, che segna al contempo l’inizio di una nuova «fase dell’esistenza», espressione semplice cara all’autore. Ma è anche un tributo tacito e di rara intensità al padre sordomuto, di cui fino a quel momento Ismail (alter ego di Kader Abdolah) era stato le orecchie e la voce.
Il racconto prende le mosse da un plico misterioso recapitato al protagonista. Un testo redatto dal padre Aga Akbar in caratteri cuneiformi, gli stessi segni indecifrabili fatti scolpire da un antico re persiano sulla parete di una grotta. Traducendo quel testo Ismail ripercorre la propria storia e quella del padre, abile riparatore di tappeti, introducendo nel panorama olandese la vista dei picchi innevati dell’Iran, dei campi di zafferano, delle donne velate dei villaggi e di quelle vestite all’occidentale delle città, e rivendicando al contempo gli ideali di giustizia e di libertà nel resistente contro l’oppressione del regime clericale.
Il topos letterario del manoscritto misterioso da cui si dipana il romanzo assume qui un significato particolare. Abdolah si rifà esplicitamente all’incipit di Max Havelaar ovvero Le aste del caffè della Società di Commercio Olandese(5) di Multatuli, romanzo fondante e rivoluzionario della letteratura nederlandese, reclamando con forza il proprio posto all’interno del panorama letterario dei Paesi Bassi. Anzi si spinge oltre, citando all’inizio del terzo capitolo uno dei testi più antichi rinvenuti in nederlandese, scritto da un monaco fiammingo del XII secolo, che così recita: «Tutti gli uccelli hanno cominciato a fare il nido/tranne io e te/che cosa aspettiamo?»(6)
Questi rimandi esprimono da un lato la caparbia volontà di affermazione dell’autore, dall’altro il desiderio di intrecciare la trama del nuovo presente di Ismail all’ordito del passato, ma rappresentano anche un omaggio alla lingua e alla letteratura, veicoli primari e universali di conoscenza e scambio tra culture diverse.
In che modo Kader Abdolah «annoda», come fossero i fili di un «inedito tappeto creolo», il passato e il presente dei protagonisti dei suoi romanzi, quasi tutti stranieri, che il destino ha condotto nei Paesi Bassi? Per esempio intessendo nella scrittura motivi, espedienti e stilemi della sua cultura d’origine. Si spiegano così le frequenti citazioni, «secondo una tradizione tutta persiana»(7), di versi di poeti della classicità – da Hafez a Kayyam – che si mescolano a quelli di autori nederlandofoni. Oppure il richiamo a passi del Corano. E ancora la descrizione di usanze, indumenti, colori o cibi del suo paese. È così che «la terra argillosa» dei Paesi Bassi, dove Abdolah ha piantati i piedi, incontra «le montagne dell’Iran», dove l’autore è nato e cresciuto e a cui torna costantemente il ricordo.
È questo l’humus in cui prende vita anche La casa della moschea(8), il romanzo con cui Abdolah raggiunge il successo internazionale e che i lettori olandesi eleggono come il secondo libro più bello scritto nella loro lingua (in Italia si aggiudica nel 2009 il premio Grinzane Cavour).
Anche qui il motivo biografico e la testimonianza politica di chi, lottando per la libertà, vede arrestare e morire persone care, fanno da sfondo a una storia che avviluppa e incanta il lettore con i suoi echi mitologici e fiabeschi, arricchiti da una forte tensione narrativa. In particolare Abdolah si fa tramite tra la cultura occidentale e quella del suo paese, narrando l’epopea di un’antica famiglia persiana da sempre custode della moschea di Senejan e i cui destini si intrecciano con quelli del popolo iraniano. Il periodo è quello tumultuoso tra lo sbarco sulla Luna (1969) e la morte della guida suprema iraniana, l’ayatollah Khomeini (1989). Un ventennio durante il quale si passa dagli stravolgimenti modernisti imposti dalla rivoluzione filo-occidentale voluta dallo Shah (il re persiano o iraniano prima della rivoluzione islamica del 1979, longa manus del potere americano) al pugno di ferro dei religiosi sciiti. Cedendo la parola a un narratore onnisciente Abdolah ci rende partecipi del vissuto di due generazioni sotto lo sguardo di chi attraversa tutto: il ricco mercante Aga Jan, stimato capo del bazar e patriarca della «casa della moschea», uomo saggio, fedele alle sue radici e a una religiosità intima e tollerante, lontana dalla radicalità oscurantista degli ayatollah. Così se nella «casa della moschea» la vita è regolata da rigide usanze secolari – non sono ammesse radio tra quelle mura e le donne indossano il chador – nulla è imposto a chi la abita, ognuno vive secondo il proprio sentire e quando la storia irromperà si assumerà la responsabilità di scegliere da che parte stare.
Abdolah mutua dalla sua cultura d’origine anche la struttura dei romanzi, optando per l’artificio della «cornice narrativa», al cui interno si susseguono racconti brevir indipendenti tra loro ma allo stesso tempo concatenati. Lo scopo, tipico persiano, è quello di «educare il lettore, intrattenendolo»(9).
L’insieme di questi espedienti, delle ambientazioni e dell’invenzione narrativa, in cui la realtà si mescola all’immaginazione, servono all’autore per farci conoscere il suo mondo. In altri termini per permettere ai lettori olandesi, e grazie alle traduzioni a quelli occidentali in genere, di conoscere e dialogare con l’Oriente. Un Oriente dove l’Islam non è quello violento di cui ci parlano le cronache ma quello pacifico di Aga Jan o della ricchissima tradizione sufi.
Attraverso una lingua che piega alla sua arte scrittoria una musicalità, un ritmo e un immaginario inediti, Abdolah costruisce un ponte quanto mai prezioso tra culture, affermando una verità che è frutto della sua personale esperienza: solo la conoscenza dell’altro ci permette di capire davvero chi siamo. Non è un caso che riservi tanto spazio nei suoi romanzi alla figura dello straniero e a immigrati desiderosi di integrazione, come i protagonisti di Un pappagallo volò sull’Ijssel(10), un titolo che è un compendio della sua opera. La ricerca di migliori condizioni di vita che spinge milioni di persone a emigrare è un processo inarrestabile, ripete come un mantra nelle interviste, un processo da accogliere come un’opportunità. La convivenza tra autoctoni e nuovi arrivati è possibile. L’apprendimento della lingua del paese ospite è una condizione essenziale per entrare a far parte della comunità, ma è anche un’occasione per arricchirla di nuovi suoni e parole, anche di esseri soprannaturali come i jinn, che vivono invisibilmente accanto agli esseri visibili. Così nasce un nuovo idioma, un idioma «esotico» per un’Olanda e un’Europa multietniche.
È nel segno dell’abbattimento delle barriere, del dilagare pacifico del sapere e della conoscenza reciproca che va letta anche la produzione di Abdolah volta a «tradurre» per i suoi lettori opere cardinali della letteratura persiana e dell’Islam. Dagli hekayat (brevi racconti didascalici) di Calila e Dimna(11) alla riduzione del Corano destinata agli agenti della polizia olandese, così come dalla vita di Maometto ricostruita nel Messaggero(12) alle storie narrate da Sherazade in Kader Abdolah racconta Le mille e una notte(13) si può leggere un gesto «politico»? La volontà di «continuare a lottare con la penna» non solo contro il regime degli ayatollah ma per una società più tollerante e più giusta? È quanto mi piace pensare, ancora di più dopo che nel maggio scorso ad Abdolah è stato conferito il Premio intercultura città di Ravenna 2024. In quell’occasione lo scrittore ha potuto percorrere le stesse strade calpestate da Dante e da Byron, poeti esuli come lui che a Ravenna trovarono accoglienza. E quando per la prima volta si è cimentato nella lettura perpetua della Divina Commedia davanti alla tomba di Dante sono risuonati i versi del XVII canto del Paradiso in farsi.
Lo studio di una lingua straniera, anche di quelle considerate a torto minori, è in sé un gesto di apertura al mondo, il primo passo di un viaggio nella conoscenza di altre genti, altri luoghi, altre visioni della vita e in definitiva di sé. A sua volta la traduzione, quando esercitata su opere di elevata complessità culturale, di forte caratura etica e di intensa poeticità, come quelle di Kader Abdolah, si rivela un moltiplicatore di conoscenze, di sensibilità e di consapevolezza, anche personale. E nel suo ruolo solo apparentemente ancillare rispetto al genio inventivo dello scrittore, stimola la creatività ed educa alla responsabilità e all’umiltà di chi è chiamato a porsi al servizio di una voce altrui, permettendo un’esperienza di rara ricchezza e intensità umana.
Note e Bibliografia
1) Con questo glottonimo si indica la lingua parlata nei Paesi Bassi e nella Regione Fiamminga del Belgio, conosciuta
prevalentemente in italiano con il nome di olandese o neerlandese e fiammingo. Nell’uso, l’etnico olandese prevale
storicamente sulle forme neerlandese e nederlandese, e le tre diverse varianti sono considerate sinonimi (cfr.
D’Achille Paolo in https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/il-neerlandese-%C3%A8-olandese-o-belga.) Da qui
l’impiego dei diversi etnici in questo testo.
2) A partire dal 2021, diversi titoli di quest’autrice sono apparsi per i tipi di Lupoguido, Milano (trad. Dafna Fiano,
Valentina Freschi)
3) Iperborea, Milano 2001
4) Iperborea, Milano 2003
5) Iperborea, Milano 2007(trad. P. Bernardini Marzolla)
6) “Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu. Wat unbidan we nu?” Così viene comunemente ricostruito un frammento rinvenuto nell’abbazia di Rochester, nel Kent, traduzione olandese di un testo latino.
7) In Elisabetta Svaluto Moreolo, Kader Abdolah, autore persiano in terra d’Olanda. Elisabetta Svaluto Moreolo intervista Natalia Tornnesello, Milano, 2020
8) Iperborea, Milano, 2008
9) In Elisabetta Svaluto Moreolo, Kader Abdolah, autore persiano in terra d’Olanda
10) Iperborea, Milano, 2016
11) Iperborea, Milano, 2010
12) Iperborea, Milano, 2023
13) Iperborea, Milano, 2023