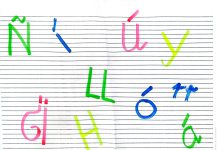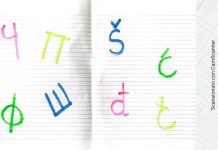di Sean Isele
Traduzione dall’inglese di Mirko Crosa
16 ottobre 1962: John F. Kennedy si riunisce con un piccolo gruppo di consulenti noto con il nome di Ex-Comm. Discutono su una risposta appropriata dopo che un aereo spia statunitense U-2 ha individuato e raccolto prove del trasporto di missili e lancia missili sovietici nelle campagne cubane. Quasi tutti i consulenti presenti nella sala riunioni alla luce delle prove davanti ai loro occhi, richiedevano una risposta militare totale, ma Kennedy non ne era convinto. Ci rifletté a lungo e cercò di capire cosa passasse per la testa dell’allora premier sovietico Nikita Chruščëv. Alla fine giunse alla conclusione che i sovietici non volevano una guerra su vasta scala, un’eventualità che avrebbe incluso anche la possibilità di un’escalation nucleare. Kennedy, opponendosi all’opinione collettiva dei suoi consulenti composti in gran parte da convinti guerrafondai, scelse di perseguire una risoluzione diplomatica. Il suo sospetto fu confermato non molto tempo dopo. Chruščëv inviò a Kennedy una lettera schietta e sincera, rivelando le proprie apprensioni riguardo alla crisi che si stava aggravando. La lettera non era la voce di un dittatore bellicoso, ma quella di un leader alle prese con le stesse paure che tormentavano il presidente americano: una guerra catastrofica che nessuna delle due parti avrebbe potuto vincere. Entrambe le parti erano in difficoltà a proporre soluzioni diplomatiche. Per Chruščëv, fare marcia indietro avrebbe potuto essere considerato un segno di debolezza, mentre per Kennedy la scelta di impegnarsi in un dialogo sarebbe potuta apparire come una mossa ingenua. Entrambi gli uomini, tuttavia, capivano che la posta in gioco andava ben oltre l’orgoglio personale o nazionale; si trattava di salvaguardare l’umanità stessa. La crisi fu fortunatamente risolta il 28 ottobre 1962, quando Chruščëv accettò di smantellare i missili a Cuba in cambio della rimozione dei missili statunitensi dalla Turchia.
Tuttavia, il momento in cui siamo arrivati più vicini alla Terza Guerra Mondiale fu probabilmente il 27 ottobre 1962, quando il sottomarino sovietico B-59, in immersione nelle acque di Cuba e armato di siluri a testata nucleare, fu accerchiato da alcune navi della Marina statunitense e fu sottoposto ad attacchi con cariche di profondità. L’equipaggio, rimasto impossibilitato a comunicare con Mosca e ignaro dell’intento statunitense di costringere il sottomarino a riemergere, credette di essere sotto attacco e che la guerra fosse già iniziata.
Il capitano Valentin Savitskij, convinto che stessero per essere distrutti, ordinò il lancio di un siluro nucleare. Tuttavia, affinché il lancio fosse effettuato, era necessario il via libera di tre ufficiali superiori, tra cui Vasilij Archipov, il secondo capitano. Archipov riuscì a mantenere la calma nonostante la pressione estrema e rifiutò di dare il suo consenso, convincendo l’equipaggio che le cariche di profondità erano solamente un segnale, non un attacco. La sua decisione impedì il lancio del siluro nucleare, e il sottomarino riemerse e si ritirò, evitando un’escalation catastrofica. All’operato di Archipov è riconosciuto il merito di aver evitato un potenziale disastro nucleare durante uno dei momenti più tesi della Guerra Fredda.
Siamo arrivati a un passo da una completa escalation nucleare e, sostanzialmente, anche dall’annientamento nucleare totale. Non aiutava il fatto che, all’epoca, la risposta statunitense a un attacco nucleare sarebbe stata il dispiegamento dell’intero arsenale nucleare statunitense, puntato non solo sull’’Unione Sovietica, ma anche sull’Europa orientale e sulla Cina. Ciò avrebbe provocato, in quel momento, un bilancio stimato di circa 700 milioni di morti in un solo istante. Questo evento scatenò importanti cambiamenti storici sul modo in cui venivano viste le armi nucleari. Era chiaro che fosse necessario uno sforzo decisivo e collettivo per regolamentarne l’uso, forse persino un disarmo nucleare completo.
Ora che comprendiamo quanto le armi nucleari ci abbiano portato sull’orlo del baratro dell’annientamento, diamo un’occhiata a come sono nate e come il loro uso si sia evoluto nel corso del tempo. Poco prima della Seconda guerra mondiale, la fisica austro-svedese Lise Meitner, che lavorava con il chimico tedesco Otto Hahn, fu tra i primi a realizzare con successo la fissione nucleare dell’uranio (quando un neutrone si scontra con un atomo più grande, inducendolo a dividersi in due atomi più piccoli), segnando l’inizio dell’era nucleare. Ben presto ci si rese conto che questo processo poteva anche essere utilizzato in un nuovo tipo di bomba. Gli Stati Uniti si unirono alla corsa con il famoso Progetto Manhattan il 13 agosto 1942, sotto la supervisione del fisico teorico e professore di fisica all’Università della California, J. Robert Oppenheimer. Il primo test riuscito, chiamato anche “The Trinity Test”, fu condotto ad Alamogordo, nel Nuovo Messico, 200 miglia (circa 322 km) a sud del sito del progetto. La bomba sperimentale, soprannominata Gadget, che conteneva 13 libbre (circa 6 kg) di plutonio, fu detonata con un sistema di detonazione a implosione.
Alle 5:29 del 16 luglio 1945, per la prima volta l’arma più distruttiva mai creata nella storia dell’umanità vide la luce del giorno.
Un lampo enorme, creato dall’esplosione di circa 21 chilotoni di TNT, accecò gli osservatori a 10.000 iarde di distanza(circa 9,1 km) . Vedendo l’esplosione e il potere distruttivo della sua creazione, Oppenheimer pronunciò: “Now I am become Death, the destroyer of worlds.”(1) Il test riuscito portò successivamente al lancio di due bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, dopo il rifiuto di una resa incondizionata da parte del governo giapponese, preannunciando la fine della guerra. I danni causati dalle bombe a Hiroshima e Nagasaki furono devastanti, con un numero di vittime che raggiunse rispettivamente 70.000 e 40.000, senza contare gli effetti successivi dell’avvelenamento da radiazioni. In un certo senso, il Progetto Manhattan e l’uso delle bombe atomiche sul Giappone, per porre fine alla guerra, costrinsero l’umanità ad addentrarsi in una nuova era atomica che avrebbe alterato per sempre la natura dei conflitti globali.
Solo quattro anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 29 agosto 1949, fu condotto il primo test nucleare sovietico in un campo di prova in Kazakistan. Ciò ebbe importanti implicazioni per l’equilibrio di potere internazionale dell’epoca. Fu uno shock per gli Stati Uniti, convinti che i sovietici fossero indietro di almeno tre anni in materia di tecnologie nucleari, il che spinse gli Stati Uniti ad adottare una politica nucleare più aggressiva, destinando più denaro e risorse alla ricerca e alla produzione di tecnologia nucleare. Credo che un approccio più diplomatico sarebbe stato più saggio ed efficace nel prevenire il dilemma di sicurezza in cui si trovarono Stati Uniti e Unione Sovietica. Sfortunatamente, come la storia ci mostra, troppo spesso la paura, l’incertezza e la diffidenza hanno prevalso sulla ragione umana. I leader si sono visti costretti a privilegiare la sicurezza e il potere del loro Stato sopra ogni altra cosa: una visione del mondo piuttosto pessimista e realistica. Questa paura e diffidenza tra Stati Uniti e Unione Sovietica portarono infine a una corsa alle armi incontrollata per la supremazia nucleare. Nel 1945 esistevano 2 armi nucleari, 304 nel 1950, 2636 nel 1955, 20.285 nel 1960, raggiungendo il picco nel 1986 con una quantità sbalorditiva, per un totale di circa 69.368 testate nucleari esistenti (Norris & Kristensen, 2010) (2). Erano condivise tra Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito, Francia, Cina, Israele, a cui si unirono successivamente India e Pakistan. Israele, India e Pakistan non fanno parte del Trattato di Non Proliferazione (NPT, o TPN in italiano). Israele, in particolare, non ha mai ammesso pubblicamente il possesso di armi nucleari fino ad oggi.
Tuttavia, ci fu un barlume di speranza in mezzo a tutta la diffidenza e il caos che caratterizzarono il periodo della Guerra Fredda. Il 10 giugno 1963, John F. Kennedy tenne quello che è probabilmente uno dei discorsi più toccanti e memorabili mai pronunciati da un presidente statunitense. In questo discorso, Kennedy non dipinse i sovietici come il male assoluto, ma come esseri umani. Sebbene le loro filosofie potessero differire, Kennedy esortò a concentrarsi sulle somiglianze invece che sulle differenze e sottolineò la necessità di rispetto reciproco e di cooperazione di fronte alle difficoltà che stavano affrontando.
«No government or social system is so evil that its people must be considered as lacking in virtue. As Americans, we find communism profoundly repugnant as a negation of personal freedom and dignity. But we can still hail the Russian people for their many achievements – in science and space, in economic and industrial growth, in culture and in acts of courage.»(3)
Presidente John F. Kennedy
Washington, D.C.
10 giugno 1963
A quanto pare, Chruščëv fu così colpito da quel discorso che non solo ne permise la trasmissione integrale, ma ne ordinò anche la traduzione completa non censurata e la ristampa sulla stampa sovietica controllata (Pravda, Izvestija), un fatto senza precedenti all’epoca. Secondo alcuni, questo fu un momento cruciale che contribuì notevolmente ai colloqui diplomatici e alla firma del Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari avvenuta solo quattro mesi dopo. Sfortunatamente, dopo l’assassinio di JFK, le relazioni peggiorarono significativamente, facendo fare una netta retromarcia alle relazioni USA-URSS.
Facciamo un passo indietro e analizziamo che ruolo ha avuto la deterrenza nucleare nella Guerra Fredda e perché sia andata fuori controllo. Le politiche e le decisioni adottate all’epoca furono senza ombra di dubbio un riflesso delle due guerre mondiali precedenti, che in qualche modo furono portatrici di lezioni contraddittorie. Da un lato, c’era la Prima guerra mondiale, che sembrava aver messo in guardia contro le corse agli armamenti e le profezie che si autoavverano. Dall’altro, c’era la Seconda guerra mondiale che aveva instaurato un clima di diffidenza nei confronti dei tentativi di riconciliazione, soprattutto tenendo in considerazione quello che accadde con gli accordi di Monaco tra Hitler e Chamberlain e il tradimento finale di Hitler. Questo sentimento e questa mentalità di diffidenza verso l’altra parte in ogni condizione e circostanza furono fortemente avvertiti e sostenuti da entrambe le fazioni, specialmente in Unione Sovietica, che aveva appena perso circa 20 milioni di persone durante la guerra. Qualsiasi tentativo di costruire fiducia sarebbe stato avversato con ogni mezzo dai più intransigenti, secondo i quali la controparte non sarebbe mai stata ai patti. Quindi, uno dei problemi che intralciarono i progressi verso accordi tanto necessari sul disarmo nucleare, e in ultima analisi sulla pace, fu la fondamentale mancanza di fiducia tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Questa preoccupazione fu ulteriormente amplificata dal fatto che entrambe le parti disponevano di armi nucleari. Un ulteriore problema era quello riassunto perfettamente dal Dilemma della Sicurezza. In breve, il dilemma della sicurezza sostiene che un’azione difensiva intrapresa da una parte sarà spesso vista come offensiva dall’altra.
Quindi, se gli Stati Uniti aumentano il loro arsenale nucleare per scoraggiare una potenziale invasione convenzionale sovietica dell’Europa, l’Unione Sovietica potrebbe interpretare ciò come una preparazione per un primo attacco nucleare piuttosto che una misura difensiva. In risposta, quando l’Unione Sovietica espande le proprie capacità nucleari per eguagliare quelle degli Stati Uniti, i radicali americani potrebbero vedere questa mossa come un tentativo di minare la deterrenza nucleare statunitense, potenzialmente per rendere possibile un’offensiva militare convenzionale. Questo circolo vizioso di diffidenza ebbe l’unico effetto di accelerare la corsa agli armamenti, costringendo entrambe le parti ad espandere i loro arsenali nucleari a livelli spaventosi in solo pochi anni. Su ogni fronte si temeva di essere vittima di un attacco preventivo. Gli Stati Uniti stavano anche valutando di condividere le loro scorte nucleari con altri stati e, eventualmente, di industrializzare e riarmare la Germania Ovest, cosa completamente inaccettabile agli occhi dei sovietici dopo ciò che avevano appena passato durante la Seconda guerra mondiale. A quanto pare, avere armi nucleari puntate addosso dal proprio giardino di casa, sotto il controllo di un paese che ti è costato più di 20 milioni di vittime, non ti fa sentire molto al sicuro. Questo stallo tra Stati Uniti e Unione Sovietica continuò negli anni fino alla caduta del Muro di Berlino e, solo un anno dopo, allo scioglimento dell’Unione Sovietica.
- [Ora sono diventato Morte, il distruttore del mondo]. A Oppenheimer, tedesco, la frase esce di getto così, con un errore grammaticale in inglese, a testimonianza della drammaticità di quegli attimi.
- R. Norris, H. Kristensen, “Global nuclear weapons inventories, 1945–2010”, in Bulletin of the Atomic Scientists, Luglio/Agosto 2010.
- [Nessun governo o sistema sociale è così malvagio che il suo popolo debba essere considerato privo di virtù. Come americani, troviamo il comunismo profondamente ripugnante come negazione della libertà e della dignità personale. Ma possiamo ugualmente salutare il popolo russo per le sue molte conquiste: nella scienza e nello spazio, nella crescita economica e industriale, nella cultura e negli atti di coraggio.]