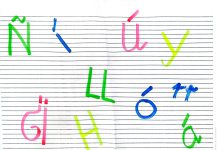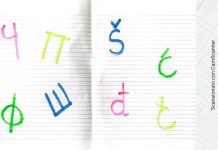di Sean Isele
Traduzione dall’inglese di Gloria Alexandra Zappalà
In questa seconda parte, ci dedicheremo principalmente ai tempi più recenti e esamineremo come il deterrente nucleare ha influenzato le decisioni in materia di politica estera. Essendo questo argomento spesso più aperto alle interpretazioni e spesso oggetto di controversie, illustrerò il mio punto di vista prendendo in considerazione anche le opinioni di stimati studiosi come John J. Mearsheimer e dell’economista di fama mondiale Jeffrey Sachs che, tra le altre cose, è stato consulente economico di Mikhail Gorbaciov e Boris El’cin.
Come accennato in precedenza, nel corso degli anni diversi Paesi sono entrati a far parte dell’esclusivo club nucleare. Ad oggi, gli Stati ufficialmente dotati di armi nucleari sono in tutto nove. Di questi nove Stati, solo cinque hanno aderito al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP): Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito. India, Pakistan e Israele non hanno mai aderito al TNP. Israele in particolare non ha mai pubblicamente ammesso né negato di possedere armi nucleari, ma in generale si crede che ne abbia. La Corea del Nord ha aderito al TNP come stato non dotato di armi nucleari, ma nel 2003 ha revocato la sua adesione. Per approfondire il modo in cui il deterrente nucleare viene utilizzato nei conflitti moderni, soffermiamoci su uno degli attuali hotspot della politica, Taiwan. Il motivo principale per cui gli Stati Uniti non sono disposti a transigere su Taiwan è la crescente influenza cinese nel teatro asiatico. Gli Stati Uniti sono attualmente impegnati in una strategia di contenimento della Cina, che aspira all’egemonia regionale, e Taiwan è un tassello vitale nel puzzle di questa strategia. Il punto è se gli Stati Uniti sarebbero disposti a proteggere i taiwanesi in caso di invasione convenzionale cinese. È qui che entrano in gioco la deterrenza e anche il deterrente nucleare.
Quando si parla di deterrenza convenzionale, le scelte possibili sono tre. La prima è convincere i Paesi avversari che un potenziale attacco si tradurrà per loro in una perdita certa. La seconda è quella di far capire che forse non sarete voi a vincere, ma che sicuramente non lascerete nemmeno che vincano loro: in altre parole, una situazione in cui tutti avranno solo da perderci. La terza e ultima opzione consiste nel convincere i nemici che la loro sarebbe una vittoria di Pirro: per vincere la guerra, pagherebbero un prezzo talmente alto che semplicemente non ne varrebbe la pena. Penso che la seconda opzione si colleghi abbastanza bene al concetto di deterrenza nucleare e di possibile escalation nucleare, con l’unica differenza che lo scenario di perdita per entrambe le parti includerebbe la distruzione reciproca assicurata. Per essere franchi: né i cinesi né i russi hanno le capacità militari per sconfiggere gli Stati Uniti in una guerra convenzionale, quindi l’unica vera minaccia è una guerra nucleare. In generale, lo scenario in cui un potente Stato dotato di armi atomiche è costretto a scegliere tra una risposta nucleare o un’imbarazzante ritirata va evitata a tutti i costi. Si potrebbe pensare che avere armi nucleari equivalga a una vittoria assicurata, ma se entrambe le parti ne disponessero la distruzione reciproca sarebbe garantita. Quindi, con l’introduzione delle armi nucleari nell’arsenale militare delle grandi potenze, l’eventualità di una guerra tra queste ultime è forse divenuta meno probabile a causa della paura di un potenziale annientamento reciproco, ma non per questo impossibile.
Oggi le armi nucleari sono più comunemente utilizzate per manipolare le strategie di rischio. Abbiamo assistito a questo scenario durante la Guerra Fredda. L’idea era che se i Paesi del Patto di Varsavia avessero invaso l’Europa Occidentale (Germania Ovest) e se la NATO avesse perso la guerra, avremmo usato le armi nucleari. Queste armi non sarebbero state dirette verso l’esercito, ma verso un’area remota, in cui nessuna parte avrebbe subito perdite. Questa azione dimostrativa sarebbe stata un chiaro segnale, per i Paesi del Patto di Varsavia, che l’Europa era seriamente intenzionata a fermare la loro avanzata, mettendo entrambe le parti, come ha detto John J. Mearsheimer in un’intervista, su un pendio scivoloso verso l’oblio. Quindi il messaggio era chiaro: l’ultima possibilità di evitare l’Armageddon è nelle vostre mani. Questa è la cosiddetta strategia di manipolazione del rischio, ed è anche ciò che potrebbe accadere nel conflitto con Taiwan e in Ucraina. Il solo uso di un’arma nucleare, senza alcuna vittima, spaventerebbe tutti in un istante proprio per la minaccia di un’escalation nucleare. Per fortuna, non sappiamo nulla di come potrebbe essere un’escalation nucleare. Pertanto, dovrebbe essere nell’interesse di tutte le parti astenersi da azioni che ci avvicinino a tale scenario. Alla luce della situazione odierna, l’Orologio dell’Apocalisse del Bulletin of the Atomic Scientists è ora a soli 90 secondi dalla mezzanotte, in cui mezzanotte significa guerra nucleare. Non ci siamo mai stati così vicino.
Credo che il motivo principale per cui ci troviamo nella situazione odierna sia la resistenza dell’egemone superstite di un mondo una volta unipolare: gli Stati Uniti d’America. Gli USA stanno attualmente cercando di resistere ai cambiamenti e alle trasformazioni che sembrano spingerci verso un mondo multipolare. Dopo la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti sono rimasti l’unica potenza egemone nel mondo. Nel bene e nel male, tutti noi siamo stati pesantemente influenzati dalle politiche estere degli USA. Molte istituzioni internazionali rappresentano una proiezione intercontinentale dell’influenza statunitense, come la NATO. Il più delle volte, la pretesa superiorità degli Stati Uniti è stata ampiamente utilizzata come etichetta e scusa per intervenire in Stati stranieri, dai brogli elettorali a una serie di operazioni di cambio di regime. Un altro errore è stato il complesso di superiorità degli americani nelle loro relazioni con la Russia. Il 2 febbraio 1990, James Baker, l’allora Segretario di Stato americano, promise a Gorbaciov che in cambio della riunificazione tedesca la NATO non si sarebbe espansa verso est. “Comprendiamo che non solo per l’Unione Sovietica, ma anche per gli altri Paesi europei è importante avere garanzie che, se gli Stati Uniti manterranno la loro presenza in Germania nel quadro della NATO, non un centimetro dell’attuale giurisdizione della NATO si estenderà in direzione est” (James Baker, 9 febbraio 1990). Gli Stati Uniti non hanno mantenuto la loro parte di promessa. Tutto è iniziato nel 1994 con Clinton, che ha pianificato l’espansione della NATO. Nel 1999 è arrivata l’adesione alla NATO di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, a dimostrazione della crescente influenza dell’Occidente nelle regioni un tempo sottoposte all’influenza sovietica. La dissoluzione della Jugoslavia dopo il crollo del comunismo nel 1991 ha lasciato la Serbia e il Montenegro come resti di una federazione frammentata. Questa Jugoslavia ricostituita è stata coinvolta in una crisi in Kosovo, una regione venerata da molti serbi come la culla della nazione sul piano storico e culturale.
La spinta all’indipendenza del Kosovo ha alimentato disordini che sono sfociati in un vero e proprio conflitto. Nel 1996, l’Esercito di Liberazione del Kosovo (UÇK) aveva preso le armi, perseguendo l’indipendenza con la forza. Sotto la guida di Slobodan Milošević, la Serbia rispose con una brutale repressione, facendo aumentare ulteriormente la violenza. Gli sforzi diplomatici dell’Occidente e della Russia miravano a mediare la crisi, ma alla fine non sono riusciti a fermare lo spargimento di sangue. In questo contesto, l’intervento della NATO è diventato non solo una risposta al conflitto del Kosovo, ma anche un momento determinante per la sua identità post Guerra Fredda.
Nonostante la NATO sostenga di essere un’alleanza difensiva, la decisione di bombardare la Jugoslavia ha rappresentato un sorprendente passaggio ad un’azione offensiva. I critici affermano che la campagna di bombardamenti non aveva tanto lo scopo di proteggere il Kosovo, quanto quello di inviare un messaggio decisivo a Milošević, l’allora Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia. Ciò dimostrava chiaramente la volontà della NATO di usare la forza contro ogni minaccia percepita ai propri valori e alla propria autorità. In 78 giorni, sul territorio jugoslavo sono state sganciate circa 420.000 bombe, colpendo non solo le installazioni militari ma anche le infrastrutture civili, tra cui scuole, ospedali e altri obiettivi privi di interesse militare. Queste azioni, che hanno inflitto pesanti perdite civili e causato una distruzione diffusa, hanno sollevato seri interrogativi sulla moralità e legalità dell’intervento della NATO.
Un’altra grande battuta d’arresto si è verificata nel 2002, quando gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente il Trattato anti missili balistici (ABM Treaty in inglese). La Russia ha considerato questo fatto come una grave minaccia per la sicurezza nazionale, perché in pratica permetteva agli Stati Uniti di lanciare un attacco preventivo, con missili posizionati a pochi minuti da Mosca. La Russia, inoltre, ha fortemente criticato la decisione degli Stati Uniti, definendola un atto destabilizzante che mina il principio della deterrenza reciproca. Il Presidente russo Vladimir Putin ha definito il ritiro un “errore” che potrebbe “scatenare una nuova corsa agli armamenti”. Il Cremlino ha sottolineato che il Trattato anti missili balistici, firmato nel 1972, è stata la chiave di volta della stabilità strategica durante la Guerra Fredda, impedendo il dispiegamento di sistemi di difesa missilistica che avrebbero potuto neutralizzare l’effetto deterrente degli arsenali nucleari.
La Russia a sua volta ha risposto accelerando lo sviluppo di armi strategiche avanzate in grado di eludere le difese missilistiche statunitensi. Queste includono veicoli ipersonici a planata, come l’Avangard, e missili balistici intercontinentali (ICBMs in inglese) come l’RS-24 Jars. Il Presidente Vladimir Putin ha giustificato questi sviluppi come necessari per controbilanciare la crescente asimmetria introdotta dalle azioni statunitensi. Ma se la Russia li presentava come provvedimenti difensivi, a Washington venivano invece visti come una provocazione finalizzata a destabilizzare, contribuendo in questo modo all’erosione del quadro normativo che permetteva un controllo degli armamenti.
Un altro punto di rottura si è verificato nel 2007, quando la Russia ha sospeso la sua partecipazione al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE Treaty in inglese). Pur non essendo direttamente collegato alle armi nucleari, questo trattato è stato cruciale per mantenere l’equilibrio militare sul continente. La sospensione di Mosca è stata dettata, in parte, dalla frustrazione per la continua espansione della NATO e dalla percezione che gli Stati Uniti non rispettassero i vincoli reciproci.
Ora, guardando indietro nel tempo, sembra che gli Stati Uniti abbiano cercato costantemente di influire su un sistema che sembra muoversi verso il multipolarismo. In questo sistema multipolare, altri potenti Stati nazionali non solo non hanno intenzione di lasciare che la politica estera degli Stati Uniti si intrometta nei loro affari, ma sono anche muniti di armi nucleari. In generale, testare i limiti di uno Stato armato di armi nucleari è una ricetta per il disastro. Gli Stati Uniti hanno inoltre abbandonato unilateralmente dei trattati fondamentali, come quelli volti a frenare la corsa agli armamenti tra con la Russia, lasciando a quest’ultima poca scelta se non quella di seguirne l’esempio. Scegliendo di uscire da questi accordi, gli Stati Uniti hanno ulteriormente accelerato la proliferazione delle armi nucleari, spingendo se stessi e i loro avversari verso una corsa agli armamenti ancora più pericolosa. In un sistema internazionale in cui il deterrente nucleare è la chiave della sicurezza, queste sono azioni sconsiderate.
Tutti sanno che la prima cosa alla quale dovremmo pensare la mattina quando ci si sveglia, oltre a preparare una deliziosa tazza di caffè, è non provocare una Guerra nucleare. Questo è l’ABC di come non distruggere il nostro mondo, quindi smettiamola di stuzzicare il can che dorme.
Ora la domanda da un milione di dollari: come possiamo evitare di farci saltare in aria e orientarci verso un potenziale disarmo nucleare? Non farò finta di avere una risposta a questa domanda, alla quale neppure i più rinomati esperti del mondo non hanno una risposta chiara. Tuttavia, farò del mio meglio per fornire la mia opinione su questo argomento così complesso.
Il Presidente Kennedy dimostrò che, anche in piena Guerra Fredda, la pace poteva essere raggiunta attraverso il rispetto reciproco e il dialogo. Il suo approccio, incentrato sulla cooperazione, sulla sfida alla percezione pubblica e sulla comprensione reciproca, è in netto contrasto con gli atteggiamenti di molti leader attuali. Oggi, l’ostentazione di ostilità, la retorica sprezzante e le iniziative unilaterali dominano la politica estera. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno costantemente ignorato gli interessi della Russia, violando impegni come la non espansione della NATO e abbandonando i principali trattati sul controllo degli armamenti. Questo antagonismo si estende oltre la politica, con tanto di boicottaggi culturali e ostracismi che approfondiscono le divisioni. In Medio Oriente, la mancanza di azioni significative per affrontare le sofferenze di massa perpetua la violenza, mentre nelle relazioni con la Cina le politiche provocatorie acuiscono inutilmente le tensioni. Una svolta verso la pace è possibile e urgente. Ma prima di pensare alla pace in sé, dobbiamo interrogarci sul nostro modo di intenderla. La pace non ci dà diritto di sbaragliare e soggiogare le culture non occidentali che non rientrano nello spettro delle democrazie liberali occidentali. Non ci autorizza a trasformare tutti i Paesi del mondo in base ai dettami delle ideologie dell’Occidente. Parlo di una pace tramite la quale possiamo ancora rispettarci e tollerarci nonostante le differenze culturali e politiche. Non ha alcun senso che alcuni leader mondiali insultino apertamente altri leader mondiali senza nemmeno un briciolo di pudore o di rispetto. Non ha senso che alcuni leader mondiali dipingano altri leader come gli eredi di Adolf Hitler, aspettandosi poi che questi ultimi collaborino quando necessario. Inoltre, è estremamente preoccupante che, oggi, molti di coloro che occupano posizioni di potere sembrino aver dimenticato la profonda responsabilità che il loro ruolo comporta e la vasta portata delle conseguenze delle decisioni che prendono.
Per fare passi avanti verso la pace vera e propria, è necessaria una solida base costruita sul rispetto reciproco. La pace non è il risultato dell’impegno di una singola nazione. È un’impresa collettiva che richiede un impegno comune. In sostanza, la pace richiede che tutte le parti rispettino e sostengano il diritto all’autodeterminazione dell’altro, promuovendo al contempo uno spirito di cooperazione volto a costruire la comprensione e l’accettazione reciproca. Piuttosto che immaginare la pace come un ideale utopico e statico, la vedo come un processo dinamico, in cui le nazioni affrontano i loro dissidi con il dialogo e la diplomazia, non con la violenza o la guerra. Un mondo in cui gli Stati non nascondono le loro intenzioni dietro le cortine fumogene della diplomazia, ma sono più trasparenti nei loro programmi e nei loro interessi. Un mondo in cui le preoccupazioni di un singolo Stato siano ascoltate e prese sul serio dagli altri Stati. Un mondo in cui la tolleranza e l’accettazione reciproca possano essere raggiunte nonostante le differenze in termini di strutture politiche, religione, cultura, ideologia e visione del mondo. Infine, vorrei concludere con una citazione estratta dal discorso ai laureati di John F. Kennedy, pronunciato all’American University di Washington D.C. il 10 giugno 1963. Penso che queste frasi descrivano bene la mentalità che gli attuali leader mondiali, i governi, i politici o noi come cittadini e individui dovremmo adottare per rendere il mondo un posto leggermente migliore e più piacevole in cui vivere.
There is no single, simple key to this peace–no grand or magic formula to be adopted by one or two powers. Genuine peace must be the product of many nations, the sum of many acts. It must be dynamic, not static, changing to meet the challenge of each new generation. For peace is a process–a way of solving problems.
Il Presidente John F. Kennedy
With such a peace, there will still be quarrels and conflicting interests, as there are within families and nations. World peace, like community peace, does not require that each man love his neighbor–it requires only that they live together in mutual tolerance, submitting their disputes to a just and peaceful settlement. And history teaches us that enmities between nations, as between individuals, do not last forever. However fixed our likes and dislikes may seem, the tide of time and events will often bring surprising changes in the relations between nations and neighbors.
So let us persevere. Peace need not be impracticable, and war need not be inevitable. By defining our goal more clearly, by making it seem more manageable and less remote, we can help all peoples to see it, to draw hope from it, and to move irresistibly toward it.
Washington, D.C.
10 giugno 1963