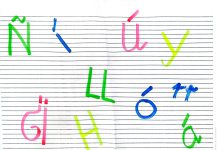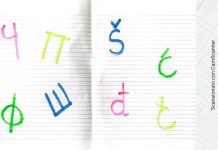Negli ultimi mesi, la piazza è tornata protagonista: centinaia di migliaia di persone hanno riempito le strade per protestare contro il genocidio che Israele sta compiendo ai danni della popolazione palestinese e contro il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Mentre CGIL e Viminale si contendono i numeri degli scioperi, noi parliamo dell’efficacia degli stessi attraverso il concetto di “mobilitazione”. Prima di iniziare preme ricordare ciò che a molti sfugge: manifestare è un diritto tutelato dalla nostra Costituzione. Criticare la scelta di manifestare solo perché le nostre idee non sono conformi a quelle dei manifestanti significa entrare in quella zona d’ombra, ambigua e instabile, della democrazia da cui è imperativo tenersi distanti. Diverso è criticare la motivazione della manifestazione, assolutamente lecito in quanto espressione di dissenso, altro diritto che non può e non deve mai essere messo in discussione. Chi è convinto che queste manifestazioni non servano a nulla deve poterlo dire, scrivere, e urlare nelle piazze. È legittimo pensarlo e in un certo senso c’è un fondo di verità: la piazza, da sola, non cambia il mondo. Ma è davvero questo il senso di una mobilitazione? Che cosa significa “mobilitazione”? Significa trasformare una situazione statica in una realtà dinamica (1).
Le manifestazioni dell’ultimo periodo non si sono limitate a cortei e slogan, ma si sono tradotte in azioni concrete: dal rifiuto dei portuali di Genova di caricare materiale bellico destinato a Israele, alla partenza di imbarcazioni con aiuti umanitari dirette a Gaza e sì, anche ai disagi. Queste iniziative sono più o meno condivisibili, ma sono concrete, sono mobilitazione. Sfidano chi, invece di farsi carico delle istanze del popolo, ne delegittima l’azione e aumenta la distanza tra i gruppi sociali.
Mobilitazione è un termine ampio che non si limita a scendere in piazza, ma comprende anche l’atto di andare a votare, per esempio. Negli ultimi vent’anni l’astensionismo è cresciuto costantemente, vuoi per strategia, sfiducia o semplicemente per disinteresse. Allora sorge spontaneo chiedersi: perché la mobilitazione dovrebbe essere divisiva? Qual è il potere del popolo senza mobilitazione? A dire il vero, a mio avviso, le ultime manifestazioni hanno riacceso quegli animi che pensavamo assopiti e la voglia di far sentire le voci che arrivano dal basso. Questo ha aumentato la spaccatura con chi, al contrario, si infastidisce per lo sciopero e per i disagi. Parlo di un divario che negli anni è cresciuto sotto ai nostri occhi in modo direttamente proporzionale alla distanza tra gli individui. Socrate diceva che “la giustizia in un uomo è come la giustizia nella polis: deve esistere armonia, cooperazione” (2). Tutti contribuiscono al bene comune e tutti soffrono quando a qualcuno capita una disgrazia. Una città ingiusta è una città in cui si creano fazioni contrapposte. Nella società odierna siamo tutti più o meno pronti a sacrificare gli altri per i nostri interessi, esistiamo in quanto individui e mai in quanto società. Eppure, la storia ci ha insegnato che i principali diritti li abbiamo ottenuti mobilitandoci, talvolta anche in modo violento: la Rivoluzione francese, i moti del 1848, la lotta partigiana, il 1968. Oggi, manifestazioni pacifiche vengono etichettate come violente per colpa di episodi marginali attribuibili a una minima parte dei presenti. La percezione è distorta: l’attenzione non si concentra su chi porta avanti un messaggio politico, ma sui disagi collaterali. È come imprecare contro la sirena di un’ambulanza senza pensare alla persona che trasporta. In realtà, la protesta non nasce per rendere la vita più scomoda, ma per ricordarci che molti dei nostri comfort esistono solo perché qualcuno, prima di noi, ha avuto il coraggio di disturbare l’ordine stabilito. Senza questa consapevolezza, rischiamo di ridurre la democrazia a un’abitudine passiva.
La realtà è che se si decidesse di scendere in piazza per l’elevata pressione fiscale, a manifestare ci andrebbero i soliti e, sempre i soliti, si lamenterebbero di chi manifesta. In tutto ciò non ci sono colpe, ma è necessario un esame di coscienza collettivo. Ognuno di noi è concentrato sullo schieramento, sull’ideologia. Pensiamo a dividerci tra destra e sinistra, ci sforziamo di rientrare nelle categorie prestabilite, cerchiamo il nemico nei gruppi lontani dal nostro. E mentre noi siamo occupati a spingerci in mare pur essendo sulla stessa barca, sotto al nostro naso fanno passare leggi mascherate da decreti-legge conditi da questioni di fiducia; provano a limitare l’azione popolare minacciando i cittadini, dimenticando di essere i loro rappresentanti; ci dicono che il diritto conta, ma solo fino a un certo punto.
Quindi forse è vero che manifestare non serve a niente, forse è vero che l’Italia da sola non fermerà il genocidio, né lo farà l’Europa, ma la mobilitazione è importante per mantenere il popolo sveglio, per mantenere vigile l’anima della democrazia, per fare pressione sui governi. Per questo motivo le manifestazioni vanno sostenute anche quando non ne condividiamo i motivi, perché i sistemi cambiano solo quando il costo di ignorare il popolo supera il costo di ascoltarlo.

Note
(1) Definizione presa dalla Treccani, potete trovarla al seguente link: https://www.treccani.it/vocabolario/mobilitazione/
(2) J. Haidt, Menti Tribali: perché le brave persone si dividono su politica e religione, Codice edizioni, 2021, p. 94.